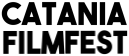“Amen”: Andrea Baroni
Un profondo perturbamento investe l’animo dello spettatore nel momento in cui si trova coinvolto nel film “Amen”, del regista Andrea Baroni, che lo ha girato con lo specifico intento (ben riuscito) di dar “fastidio” al pubblico.
Le protagoniste, tre giovani ragazze, sono cresciute dalla nonna Paolina, che cerca di educarle secondo le Sacre Scritture, che, però, interpreta con un così eccessivo rigore, da creare quasi una religione propria, i cui seguaci spera che siano le nipoti e il figlio. Le fanciulle si ritrovano, infatti, in una condizione di oppressione, non solo per la limitatezza spaziale in cui sono costrette a vivere, ma anche e soprattutto per i confini che si vedono imposti nei confronti di sogni, pensieri e desideri. La rigidità dell’educazione le porta, dunque, a commettere quelli che Paolina chiama “peccati di evasione”, immaginando di vivere in una realtà diversa: dall’estremismo, infatti, sfocia sempre la trasgressione vera e propria, proposta alla protagoniste proprio dalla nonna, che le mette alla prova invitando a risiedere nel casolare Primo, un suo cugino. Due delle tre ragazze, Sara ed Ester, sono ormai donne e si ribellano alla morale per la quale sono state cresciute in modi diversi: la prima si sente in colpa e ha paura dei suoi “peccati di evasione”, che commette, però, sotto l’influenza della seconda, la quale, invece, insorge anche verbalmente contro il padre Armando e la nonna Paolina.
Primo è un “pezzo di carne”, come lo definisce Andrea Baroni stesso, perché è concretamente lo strumento di cui la capo famiglia si serve per accertarsi che la fede delle due sorelle maggiori sia realmente forte e che i suoi insegnamenti siano fruttati. Quest’uomo fa commettere loro il più comune (il “primo”) peccato della storia dell’umanità: quello di cedere alla corporeità. Sara ed Ester peccano di fornicazione e vengono punite con la morte, subendo lo stesso destino cui è andata in contro, anni prima, la madre, attorno alla quale essenza ruota l’intero film. Scaturisce al seguito di tale atto estremo l’ipocrisia di questo mondo: può essere considerato cristiano colui che punisce con la morte, se uno dei dieci Comandamenti invita proprio a non uccidere ed il Vangelo invita ad amare il prossimo come se stesso? Il padre era consapevole che ciò, con molta probabilità, sarebbe accaduto, tanto da assumere nei confronti delle tre giovani un atteggiamento aggressivo per non farle cadere in tentazione, finché non percepisce l’incombenza del pericolo, proponendo alla figlie di scappare, ma troppo tardi, quando il loro destino è già segnato.
Il fastidio risiede proprio nell’estremismo: lo spettatore si riconosce, ma non del tutto, nell’elemento esacerbato, che può non essere esclusivamente religioso, ma anche, ad esempio, lavorativo: c’è chi fa del lavoro la propria religione! Sono, infatti, tanti gli elementi della vita che si considerano “sacri”, che vengono resi, cioè, dei capisaldi intoccabili, sfociando, poi, nell’ipocrisia.
Il personaggio più complesso, infatti, è proprio il padre delle tre ragazze, che è allo stesso tempo vittima e carnefice: vittima perché ingabbiato dal senso di colpa dell’uccisione della moglie e delle due figlie maggiori, carnefice perché accetta di vivere in questa condizione carceraria, tanto da dormire nello stesso letto con la propria madre, avendo strutturato con lei un rapporto morboso, quasi incestuoso. Comprende che è giunto il momento di sottrarsi a questa realtà quando sa di essere sul punto di perdere due delle sue figlie, che, come ricorda Paolina, sono rami di una stessa pianta la cui radice è marcia: hanno ereditato la peccaminosità dalla madre. Nel film, infatti, sono diverse le scene in cui le fanciulle mangiano con avidità dei fichi maturi, tanto che nella conclusione, Sara, che doveva essere d’esempio per le sorelle, afferma di non essere pentita per il peccato commesso.
Nonostante il regista abbia affermato di non aver avuto a disposizione un cospicuo budget per la realizzazione di questo film, ciò non ha intaccato la qualità dello stesso. Le scene di un’apparente tranquillità quotidiana sfociano poi nelle successive di disperazione e tormento: stati d’animo la cui intensità si acuisce sempre più con il susseguirsi degli eventi. Nessun dettaglio è casuale, tutto è studiato, fino all’ultima scena in cui la sorella più piccola, Miriam, scappa al di là della vallata che separa il casolare dalle realtà esterna. Tuttavia, mentre la ragazza ammira l’alba e il cielo sconfinato, giunge sulla scena la nonna, che viene, però, inquadrata lateralmente dalla cinepresa. È compito dello spettatore immaginare il finale: la giovane ragazza è riuscita a sottrarsi dalla realtà estremista in cui è cresciuta o ne rimarrà ingabbiata ancora per diverso tempo? L’incertezza di un possibile finale negativo va ad acuire ancor di più il senso di fastidio tanto ricercato dal regista Andrea Baroni.
***************************
“L’eternità e un giorno”: Angelopoulos
“Che cos’è il tempo? Il tempo è un bambino che gioca ai cinque sassi sulla riva del mare”. È così che inizia il film “L’eternità e un giorno” del regista Angelopoulos, con una citazione di ispirazione eraclitea, secondo cui gli uomini sono “esseri giocati” e non giocatori in prima persona all’interno del “gioco cosmico” del tempo, paragonato ad un bambino che lancia dadi casualmente o per raggiungere un fine contingente.
Il protagonista è Alexandros, un uomo che un tempo fu un grande poeta, ma che, nel presente, non riesce a concludere più nulla, neanche i libri che avrebbero dovuto costituire i suoi capolavori, perché non è in grado di trovare le parole adatte. Quest’uomo vive “da esiliato la sua stessa vita”, finché non incontra un bambino albanese, che salva dagli sfruttatori dei minori e dalla compravendita illegale che interessa questi ultimi. Mentre Alexandros trascorre gli ultimi giorni della sua vita ed è prossimo al decesso, il fanciullo (di cui, non a caso, non viene rivelato il nome) rappresenta, invece, la giovinezza, che, nonostante le difficoltà, è caratterizzata da un ardore inarrestabile. Tuttavia, ad un altro bambino, Selim, è riservato un destino piuttosto diverso: morire nel fior degli anni. “Selim parlaci, parlaci di questo vasto mondo” chiede disperatamente il giovanissimo albanese: queste parole rivelano un forte desiderio di riscatto, di vita e di conoscenza, desiderio che ogni migrante coltiva nel proprio cuore, dopo aver affrontato numerosi pericoli in cerca di un futuro migliore. Nella microstoria di “L’eternità e un giorno”, dunque, si cela una macrostoria relativa alla migrazione, perché ogni uomo viaggia, pur compiendo delle brevi tratte, per conoscersi e realizzarsi al meglio. Come Alexandros sottrae il bambino albanese da una triste realtà, allo stesso modo quest’ultimo gli restituisce le parole di cui aveva bisogno per esprimere il proprio stato d’animo. Questo gioco scaturisce al seguito della rievocazione della personalità di Solomos, un poeta che visse per tanti anni in Italia, e che ritornò a Zacinto nel momento in cui venne a sapere che i greci si stavano ribellando contro gli Ottomani. Avendo trascorso molto tempo lontano dalla sua terra, gli mancavano le parole per esprimere la condizione della propria patria e, perciò, cominciò ad acquistarle da pescatori e contadini: pagava chiunque gli insegnasse un nuovo termine, che appuntava meticolosamente per poi scrivere delle poesie. Le parole apprese da Alexandros sono, invece, “κορφούλα μου”, cioè fiore prezioso, riferito agli affetti familiari, “ξενίτης” per indicare uno stato d’animo che consiste nel sentirsi stranieri ovunque e “αργαδινή”, che significa “molto tardi nella notte”, perché il protagonista si è reso conto troppo tardi di ciò che veramente conta nella vita.
La moglie di Alexandros, Anna, costituisce un altro personaggio fondamentale della storia. Il protagonista, infatti, ripercorre i propri ricordi per via del rimorso di essere stato poco presente nei suoi confronti, perché sempre assorto nei pensieri e nella scrittura. All’inizio del film, infatti, l’uomo trova una lettera scritta dalla donna amata, che gli chiedeva di “regalarle un suo giorno”, anche se consapevole di non appartenere allo stesso mondo del marito. Questo rimorso, come ha rivelato Amedeo Pagani, produttore cinematografico di “L’eternità e un giorno”, tormentava anche l’animo di Angelopoulos, che riteneva di aver dedicato scarse attenzioni alla moglie Phoebe, dato che si rinchiudeva egoisticamente nella dimensione cinematografica. È, infatti, tentazione della persona talentuosa rifugiarsi nell’ambito della propria arte per perfezionarla al meglio, ma vale la pena vivere la propria esistenza da “esiliati”, lontani, quindi, dai propri cari, per poi giungere in fin di vita nella stesse condizioni di Alexandros, che lasciò gran parte del suo operato in uno “stato di abbozzo”? Il protagonista, ogni mattina, è il destinatario di una meravigliosa musica cui, però, non risponde. Alla madre, infatti, nel momento in cui le dice addio, chiede: “Perché niente accade come vorremmo? Perché dobbiamo marcire in silenzio tra dolore e desiderio?”. Si tratta di domande comuni, che accomunano tutta l’umanità e la cui risposta si trova, probabilmente, grazie alla metafora che apre l’intero film.
Il susseguirsi delle scene procede con lentezza, affinché ogni singola goccia di “umidità” (termine utilizzato da Angelopoulos stesso per fare riferimento alla propria ispirazione) del regista possa penetrare delicatamente nel cuore degli spettatori, poiché ogni simbolo è essenziale. Le immagini sono caratterizzate da inquadrature spaziali ampie, raffiguranti paesaggi immensi, in contrasto con la piccolezza della natura umana. Il film, purtroppo, non è alla portata dei giovani, che riescono a seguire esclusivamente le azioni lineari. Angelopoulos, infatti, fonde due linee temporali, passato e presente, i cui legami sono molto labili. Tuttavia, vale la pena concentrarsi e riflettere, per poter comprendere al meglio questo capolavoro del cinema greco. Alcuni temi, come quello del vecchio che ricompone i frammenti del proprio passato con l’aiuto del bambino e del viaggio per riscoprire se stessi, sono archetipo della letteratura greca, al fine di accentuare ancor di più l’idea della continuità del passato, perché le necessità dell’uomo sono sempre state le stesse.
La narrazione si volge al termine nel momento in cui Alexandros e il bambino albanese decidono di andare incontro ad un’ultima avventura prima di dirsi definitivamente addio; salgono su un autobus in cui si concretizzano un uomo che regge la bandiera dell’Albania, per rappresenta l’amore per la propria patria; dei musicisti, che stimolano con le loro note la consapevolezza interiore del vecchio e del bambino; un uomo ed una donna, la cui storia d’amore sembra in crisi; Solomos stesso, che recita una poesia sulla dolcezza della vita, che, “come l’ultima bolla di rugiada all’alba, annuncia un sole limpido”. Conclusa quest’esperienza, il bambino parte per l’Albania e Alexandros dovrebbe dirigersi in ospedale per curarsi. Tuttavia, interiormente si ribella e cambia meta, recandosi nella casa al mare che la figlia ed il genero hanno venduto. Si insinua, così, la tematica del futuro: “Tutto è verità, tutto è attesa della vita. Il domani, cos’è il domani Anna? Una volta ti avevo chiesto quanto dura il domani”. Tuttavia, per Alexandros non c’è alcun futuro, perché il domani dura “un’eternità e un giorno”: la vicenda si svolge nell’arco di ventiquattro ore, tutto il resto è dilatazione temporale nel passato e, infine, nel futuro, perché, realisticamente, al protagonista non resta nulla da vivere.
Recensioni a cura di Giuseppina Maria Gliozzo (Istituto San Giuseppe)